Non ancora quattordicenne, ma già pieno d’impulsi dinamici, fui dal mio tutore (non conobbi il bene delle carezze materne) inviato a Milano a lavar piatti, primo gradino della carriera culinaria, e ciò contro la mia vocazione. Già per natura d'indole ribelle, mordevo il morso, almanaccando che il destino mi porgesse il destro per sottrarmi a quella catena, giudicando impossibile assoggettare il mio temperamento a freni che mi erano imposti da volontà non mie.
E il tanto vagheggiato destro mi fu offerto un giorno che, di ritorno con la cesta della spesa giornaliera, stavo in Piazza d’Armi, incantato ad osservare l'esercizio di una Compagnia di coscritti. Poco discosti da me si trovavano tre “Globe trotters” (giramondo). Cappello alla tirolese, con l’immancabile piuma di fagiano, zaino in ispalla e nude le gambe dai ginocchi alle caviglie. Non potevo più staccare i miei occhi da quei tre giovanotti dall'aria nordica. Il più anziano venne verso di me ed in francese (io avevo frequentato la scuola maggiore) mi domandò perchè li fissavo così indiscreto. Risposi che m'interessava di sentirli parlare di viaggio in America e che ardevo pure dal desiderio di partire. Alla domanda dell'età e se ero Milanese, risposi ch'ero Svizzero e raccontai tutta la mia odissea. Alla parola Svizzero i loro occhi ebbero un lampo - mi vidi salvo - e mi dissero che erano: un Germanico, un Belga e un Olandese in viaggio per l'America. Erano venuti a piedi dopo aver risalito tutto lo stivale italico. Il loro itinerario era di attraversare la Svizzera, la Germania, il Lussemburgo, l'Olanda, il Belgio, la Francia e di arrivare così a Le Havre. Mi chiesero se mi sentivo di fare tutta quella strada a piedi e come loro... senza soldi... vivendo delle “bricoles” che si sarebbero presentate. Non li lasciai finire e, senza recriminare, mi misi a loro disposizione. Nel provvidenziale cesto v'erano polli, salumi, formaggio e pane, e tutto questo ben di Dio venne con noi. In quel tempo, le “Carte” non erano tanto necessarie per chi teneva buona condotta e aveva un pochettino di audacia. Prendemmo quindi per I'Arco del Sempione e via alla Cagnola (sobborgo milanese). In tre giorni arrivammo a Chiasso, dopo aver fatto tre “bricoles”. Ero... a casa mia, ma avanti! A Lamone vidi il laghetto di Ponte-Tresa e la vetta del Lema, ebbi un tuffo (erano i miei paraggi), ma ... avanti. I piedi cominciavano a sanguinare, ma l'ardore dell'impresa m'infervorava e dopo tre settimane si giunse a Basilea. Traversato il Reno si puntò su Berlino, dove il Germanico aveva dei parenti, e... ancora avanti. Il Belga, un Fiammingo, volle pure visitare i suoi e dopo due giorni eravamo di nuovo in viaggio per Amsterdam. Altro riposo breve, quindi via per la Francia. A Parigi, il caso mi fece incontrare dei Malcantonesi, e mercè loro potemmo lavorare per il Municipio parigino a pitturare di verde le panchìne dei Campi Elisi. Così, avendo una trentina di franchi ciascuno, ci ritenemmo ricchi. E si arrivò a Le Havre, con l'Inghilterra di fronte a... due passi. Quant'acqua e ... niente soldi! E là, dopo circa cento giorni di viaggio e calpestati oltre 3000 chilometri esotici, si presentò per la prima volta un problema non del tutto facile da risolvere. A piedi in America non si giunge, e per prendere il bastimento ci vogliono pure soldi. (In quei 100 giorni acquistai più esperienza che in 20 anni nel mio villaggio). "Cicchetti - mi confortò il mio anziano - se non ci fossero difficoltà da superare non arriveremmo ad essere uomini in tutta l'espressione del termine". Ma a me quel "Cicchetto" non andava giù, e già cominciavo a frignare. "Voilà pelit Suisse, gardez-vous - mi refilò l'anziano - à chaque jour suffit sa peine". Capii l'antifona al volo e ridivenni il... "lingerela" pronto anche senza... cicchetto. L'anziano si rivolse subito ad un capitano di marina in partenza appunto per l'America. E fummo accettati (oggi è proibito); lavorando a bordo avevamo vitto, alloggio e viaggio gratis. Era quello che ci voleva per me. E il giorno appresso si lasciò Le Havre, emporio di navi, foresta d'antenne e di fumaioli, nonché babilonia di idiomi. I miei compagni furono assunti come falegname, verniciatore, e l'ultimo come mozzo, mentre io fui relegato in cucina. Mi ritenevo più che fortunato e toccavo il cielo col dito, ma... ahimè, non avevo fatto il conto con la burrasca. Non mi si dica che il mal di mare lo sentono solamente coloro i quali fanno il primo viaggio, oppure che si abbia una tempra da signorinella, chè di viaggi in mare ne feci parecchi, ma il mal di mare ho dovuto, a mo' degli altri, subirlo anch'io. L'equipaggio medesimo difficilmente può sottrarsene (ben inteso quando la burrasca è ... coi fiocchi) e di questi "cicchetti" in 48 giorni di traversata se n'ebbe più di uno.
Vorrei domandare a quei Malcantonesi che fecero il viaggio d'America se hanno attraversato il Golfo del Leone nel Mediterraneo, il Golfo di S. Catalina nell'Uruguay o lo Stretto di Magellano in fondo alla Patagonia nel Chile, senza burrasca. II mal di mare non è affatto una malattia, ma un senso di spossamento prodotto dal rullio e dal beccheggio del vapore. Non v'è nessuna medicina, ed ognuno deve ingegnarsi come può. Per tutto il perdurare della tempesta, non si ha voglia di mangiare e si è tormentati da un continuo vomito che produce una bava verde. Chi si rivolge al medico di bordo per tal male, viene respinto; secondo i miei esperimenti, l'unico sollievo è di mettersi bocconi e di non muoversi. Ma qui vi è un inconveniente! Troppo poco spazio. Infatti, chi è sdraiato o seduto occupa maggiore spazio di chi rimane in piedi e nel caso specifico... son dolori.
A Rio de Janeìro, nel Brasile, ero anch'io bramoso di vedere l'Imperatore di quell'immenso Stato (allora ancora Impero), una popolarissima persona dalla barba bianca e con panama a grande tesa, Don Pedro II d'Este. Il mio desiderio fu soddisfatto. Sul gran Boulevard Rio Branco l'incontrai che distribuiva confetti: ai bambini, mentre i passanti lo riverivano.
Giungemmo a Montevideo, nell'Uruguay, bellissima città mollemente adagiata su una non ripida collina, con il suo "Cerro" (rupe) di 300 metri circa di altezza, con il suo forte alla sommità (visto dal basso assomiglia ad un'immensa cucina economica). Curioso particolare: ai suoi piedi vi è la foce del grande fiume "La Plata" che dalle Amazzoni e per oltre 5000 chilometri viene a Montevideo a congiungersi con l'Oceano. L'esatto confine delle due acque, la dolce e la salata, è tracciato da una riga galleggiante e spumosa, larga 4 metri circa, che mai si disgrega e distingue nettamente l'acqua marina da quella del fiume di color giallo, dovuto alla gran massa di sabbia che dalle Ande convoglia. Quella "riga" è lunga circa 100 chilometri, cioè la larghezza del fiume. Lasciamo Montevideo e saliamo il fiume "La Plata" fra due file di boe galleggianti che indicano la rotta ai piloti per preservarli dei banchi di sabbia, e si arriva a Buenos Aires, immensa metropoli argentina, tutta piatta e con pochi grattacieli causa l'instabilità del terreno, e che con le sue case basse la rende più ampia di Parigi. Sbarcati, siamo condotti al capannone dell'emigrazione dove si dorme sulla sabbia senza ritegno fra i due sessi. Al terzo giorno (sempre trattasi di emigranti) tutti devono lasciare il capannone e si è alfine liberi. Chi ha conoscenze viene ospitato e provvisto di lavoro; chi invece non ne ha come nel caso mio, deve ingegnarsi. E qui... son tormenti se si è senza appoggio e, per di più, profani nella lingua. Mi trovai in un'ampia piazza, scoraggiato e solo; i miei compagni di viaggio dall'Emigrazione furono impegnati nell'interno della Repubblica. Ad un tratto mi giunge all'orecchio la parlata lombarda; erano due muratori del Comasco che si recavano al lavoro. Rinvenni quasi dalla gioia, e mi diressi verso di loro. Saputo il caso mio e che ero Luganese (essi avevano già lavorato a Lugano), persero volontariamente la mezza giornata e mi condussero dal nostro Console. Questi, un gentilissimo Friborghese, scorse a lungo la lista dei residenti ticinesi e mi mise in relazione con un impresario gessatore, un certo Fasola di Cadro il quale mi occupò come manovale, ma la paga era troppo misera e la vita colà era troppo cara. Facendo parte della Società filantropica svizzera, il cui presidente era il nostro console, mi raccomandai a lui per poter entrare nelle Poste argentine. Il direttore generale era un Parigino ed essendo io uno Svizzero, mi accettò senz'altro, destinandomi come "estafetero" (impiegato postale sui treni). Era il mio ideale a non star fermo. Ma dopo poco tempo seppi che quelle linee erano infestate dai «gangster» (banditi), già impiegati dell'ambulante, licenziati per cattiva condotta e furti postali. Valendosi della conoscenza del servizio, con segnali luminosi ed in piena campagna fermavano i treni e ne rubavano i plichi con denari; l'impiegato minacciato, se protestava, veniva subito freddato. Trattandosi della mia linea, di circa 5000 chilometri, e siccome si ritornava solamente ogni quindici giorni, tali attentati erano piuttosto frequenti. Benchè ancora incolume, ma troppo mal impressionato, rassegnai le dimissioni e continuai a fare il gessatore. Ma siccome la mia viva passione era quella di viaggiare, dopo sei anni di residenza e sottoposto alla leva militare, ritornai in patria per frequentare la Scuola reclute, e pochi mesi dopo fui assunto quale impiegato del treno nella "Gotthardbahn".
Almanacco malcantonese e della bassa Valle del Vedeggio, 1948.
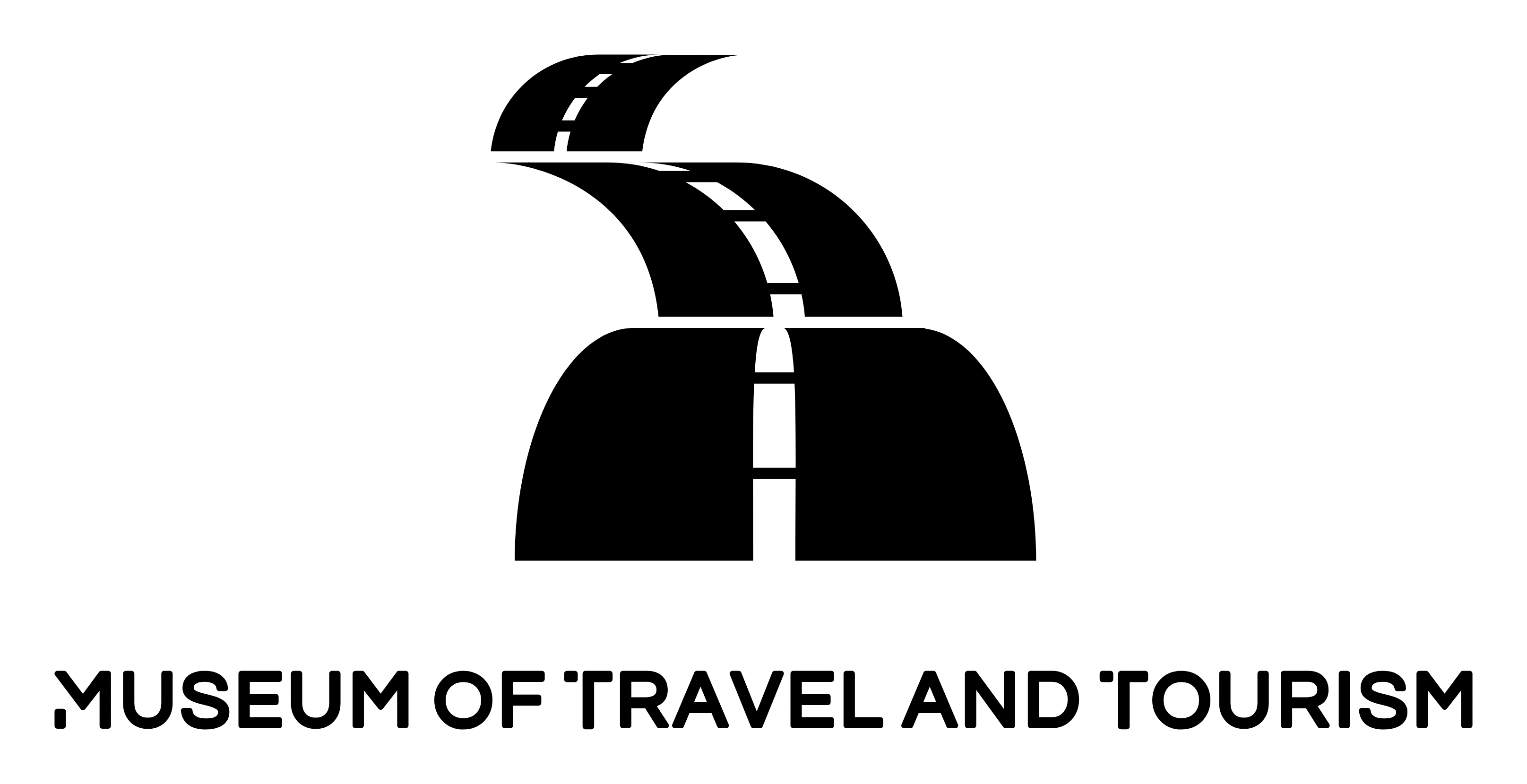
 IT
IT  FR
FR  DE
DE  EN
EN .jpg)