Negli ultimi anni l’aviazione è diventata uno dei bersagli preferiti del dibattito ambientale. Ma cosa ci dicono davvero i dati? È corretto parlare di “vergogna di volare”? Un’analisi attenta delle fonti statistiche mostra una realtà ben più complessa e sfumata. Il trasporto aereo rappresenta solo una piccola frazione delle emissioni globali e metriche comparate rivelano che altri mezzi, spesso percepiti come “più verdi”, non sono necessariamente più sostenibili. Questo breve articolo invita a riflettere, con numeri alla mano, su quanto sia importante distinguere tra percezione e realtà nei temi ambientali (e non solo).
Impronte ecologiche non lineari
Sarà capitato a tutti di imbattersi in articoli di giornali o di blog che riportano notizie ansiogene sull’impatto ecologico degli aerei. Si citano cifre, ricerche scientifiche e interviste ad autorevoli esperti: le tesi che emergono con una malcelata enfasi sono relative ad un uso irresponsabile di questo mezzo di trasporto, accusato di inquinare più di altri mezzi o addirittura di essere una delle principali cause dei cambiamenti climatici d’origine antropica. Gli articoli si spingono fino a sostenere la necessità di introdurre un controllo sociale grazie alla cosiddetta “vergogna di volare” (shame of flight). Ma è davvero così? Cosa ci dicono le fonti statistiche? Dobbiamo vergognarci quando saliamo su un aereo?
Per rispondere in sintesi a questi potenziali dilemmi, va subito rilevato che il trasporto aereo è responsabile del 2% del volume globale di emissioni: in altre parole i sedicenti esperti omettono un’informazione non proprio trascurabile, ovvero che il 98% delle emissioni è causata da altre attività umane. Nel dettaglio, il settore genera:
- Emissioni di gas serra (inclusi tutti i gas, non solo la CO₂): secondo i dati di Our World in Data, il settore dell'aviazione rappresenta circa l'1.9% delle emissioni globali di gas a effetto serra (GES).
- Emissioni globali di CO₂: l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) indica che le emissioni di anidride carbonica prodotte dal trasporto aereo rappresentano meno del 3% delle emissioni globali di CO₂ prodotte dalle attività umane.
- Considerando il forzante radiativo, il contributo complessivo dell’aviazione al riscaldamento globale è stimato attorno al 3.5-5%.
Secondo i dati di Our World in Data, il settore dei trasporti contribuisce a circa il 24% delle emissioni globali di CO₂. Di queste emissioni, la suddivisione per modalità di trasporto è la seguente:
- Trasporto su strada: rappresenta circa il 72% delle emissioni del settore dei trasporti. Questo include le autovetture private (circa il 45.1% delle emissioni del trasporto su strada), gli autocarri leggeri e pesanti (circa il 29.4%), gli autobus (circa il 3.6%).
- Aviazione: contribuisce per circa l'11.6% alle emissioni del settore dei trasporti.
- Trasporto marittimo: circa il 10.6% delle emissioni del settore.
- Trasporto ferroviario: è responsabile di una piccola frazione delle emissioni del settore dei trasporti, grazie all'elevata efficienza energetica e all'uso diffuso dell'elettrificazione.
Le notizie evidenziano come le emissioni derivanti dall'aviazione siano raddoppiate dalla metà degli anni Ottanta del Novecento ad oggi. Questo dato è corretto, ma spesso presentato senza il necessario contesto: nello stesso periodo, anche le emissioni totali di CO₂ sono cresciute a un ritmo analogo. Di conseguenza, la quota dell'aviazione rispetto alle emissioni globali è rimasta stabile, attestandosi indicativamente tra il 2% e il 2.5%.
È importante sottolineare che valutare l’impronta energetica dei mezzi di trasporto è un tema complesso. Tra le molte metriche sviluppate negli ultimi anni, quella proposta da Vaclav Smil risulta particolarmente interessante, poiché consente di confrontare i diversi sistemi di trasporto in base all’energia necessaria per spostare una persona per un chilometro (MJ/pkm):
- Metropolitana (ora di punta): 0.1 MJ/pkm
- Treno intercity: 0.2–0.4 MJ/pkm
- Utilitaria (1–2 passeggeri): 1–2 MJ/pkm
- Aereo di linea: 1.5–2 MJ/pkm
- SUV (1–2 passeggeri): 3–5 MJ/pkm
L’analisi dell’efficienza energetica relativizza almeno in parte le tesi che puntano a colpevolizzare il trasporto aereo, soprattutto se i dati vengono ponderati con la frequenza degli spostamenti con i diversi mezzi. Si tratta evidentemente di metriche che possono essere adattate in funzione dei propri scopi: le visioni più negative si basano frequentemente su ipotesi non sempre dichiarate, in particolare riguardo al tasso d’occupazione dei vettori. Questo è un punto cruciale per ottenere dati coerenti: troppo spesso si assume un’occupazione massima teorica per i bus o i treni, ignorando il tasso medio reale, che risulta più rappresentativo delle condizioni effettive di utilizzo.
Un ultimo aspetto che spesso viene trascurato riguarda l’energia necessaria per costruire e mantenere le infrastrutture di base (aeroporti, stazioni, binari, strade, parcheggi, ecc.). Questo elemento ha un impatto significativo sulla valutazione complessiva delle diverse modalità di trasporto utilizzate per lo spostamento di persone e merci. Le analisi convenzionali non includono questo fattore, ma studi più completi di tipo LCA (Life Cycle Assessment) mostrano che strade e ferrovie possono avere un impatto infrastrutturale maggiore rispetto agli aeroporti, soprattutto a causa della loro estensione territoriale e dei costi di manutenzione distribuiti nel tempo.
- Aerei: gli aeroporti hanno un impatto relativamente minore se confrontati a autostrade o ferrovie perché non c’è necessità di infrastruttura lineare continua; un grande volume di passeggeri è concentrato su poche infrastrutture.
- Auto: le reti stradali hanno un’enorme estensione, con alti costi ambientali e manutentivi (asfalto, illuminazione, svincoli, parcheggi, stazioni di servizio).
- Treni: richiedono un’infrastruttura molto energivora (binari, elettrificazione, stazioni, ponti, gallerie).
La lotta a un inquinamento meno visibile
Anche sul fronte dell'inquinamento acustico emergono differenze significative. Gli aerei generano livelli sonori molto elevati, in particolare durante decollo e atterraggio, che possono incidere negativamente sulla qualità della vita nelle aree urbane vicine agli aeroporti. Tuttavia, questi eventi sono limitati nel tempo e nello spazio, e le tecnologie più recenti hanno ridotto sensibilmente il rumore prodotto dai nuovi modelli di aeromobili.
Al contrario, il traffico automobilistico produce rumore in modo continuo e capillare, influenzando grandi porzioni di territorio, soprattutto lungo arterie stradali e nei centri abitati. Si tratta della principale fonte di esposizione al rumore ambientale cronico in Europa, con effetti documentati sulla salute, tra cui disturbi del sonno e aumento del rischio cardiovascolare.
I treni, pur generando emissioni sonore rilevanti, concentrano l’impatto acustico lungo assi ben definiti e in tempi prevedibili, consentendo in molti casi interventi efficaci di mitigazione (come barriere o isolamento acustico). Anche in questo ambito, quindi, il bilancio complessivo dipende fortemente dal contesto urbanistico, dall’intensità del traffico e dalla qualità delle infrastrutture.
Economia e sicurezza
L'industria aeronautica riveste un ruolo importante nell'economia mondiale, contribuendo con miliardi di dollari e offrendo milioni di posti di lavoro distribuiti in tutti i continenti. A livello globale, il mercato dell'aviazione generale è stato valutato a 35.15 miliardi di dollari nel 2025, con una previsione di crescita a 43.11 miliardi di dollari entro il 2030. Inoltre, nel 2023 sono stati effettuati 34.4 milioni di voli, evidenziando l'importanza del settore nel facilitare il commercio e la connettività globale. Questi dati sottolineano l'importanza economica dell'industria dell'aviazione, sia in termini di valore economico che di occupazione a livello globale.
Un aspetto spesso trascurato nel confronto tra modalità di trasporto è quello della sicurezza. I dati disponibili evidenziano che, per chilometro percorso, l’aereo è il mezzo di trasporto più sicuro al mondo. Secondo le statistiche dell’International Air Transport Association (IATA), nel 2023 si è verificato un solo incidente grave ogni 2.26 milioni di voli. La mortalità per passeggero-chilometro è inferiore a 0.1 decessi per miliardo di chilometri, un valore estremamente basso grazie all’elevato grado di automazione, agli standard internazionali di manutenzione e formazione, e alla gestione centralizzata del traffico aereo.
Anche il treno è considerato molto sicuro, soprattutto nei paesi dotati di infrastrutture moderne e sistemi digitalizzati: la mortalità media si aggira tra 0.2 e 0.5 per miliardo di passeggeri-chilometro. In netto contrasto, l’automobile - pur essendo il mezzo più diffuso - è anche il più pericoloso: i tassi di mortalità oscillano tra i 5 e i 7 decessi per miliardo di chilometri percorsi in Europa, e sono ancora più alti in altre regioni del mondo. La guida privata, con la sua forte esposizione all’errore umano, rappresenta la principale causa di morte per i giovani a livello globale, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Questi dati sottolineano l’importanza di considerare la sicurezza non solo come una questione tecnica, ma come un parametro centrale nella pianificazione di una mobilità davvero sostenibile.
Interconnessioni sociali
Una dimensione raramente considerata riguarda l'impatto sociale delle connessioni generate dal viaggiare. L’aumento della mobilità internazionale ha favorito, soprattutto negli ultimi decenni, una prossimità tra persone e comunità altrimenti lontane, contribuendo a ridurre incomprensioni culturali, pregiudizi e conflitti. È un effetto che non si presta a una facile misurazione, ma che potrebbe manifestare un peso considerevole nel lungo periodo: più viaggi e più interazioni possono significare maggiori occasioni di confronto, di empatia, di apprendimento reciproco. In una prospettiva storica, la facilità di viaggiare rappresenta forse uno degli antidoti più efficaci contro le tensioni che hanno segnato secoli di conflittualità tra popoli e nazioni. Evidentemente è questo un tema complesso e che presenta criticità importanti, soprattutto in relazione alle forme di turismo post-fordiste e all’overtourism, dinamiche sociali che possono esacerbare conflitti e incomprensioni.
Ripensare la mobilità sostenibile
L’inquinamento causato dall’aviazione è uno di quei temi prediletti da alcune correnti di pensiero, retaggio di un’epoca in cui si accusavano le scie degli aerei di causare il raffreddamento globale, una teoria in voga fino agli inizi degli anni Ottanta del Novecento. In una visione più strutturata e documentata, queste narrazioni non hanno riscontri rilevanti: la vergogna per chi si imbarca al gate è certamente fuori luogo e gli appelli che ne fanno uso non solo sono inutili, ma anche controproducenti, visto che distolgono l’attenzione da settori che richiedono maggiori interventi e attenzioni. In tal senso sono esplicative le statistiche che riguardano l'evoluzione delle emissioni:

https://ourworldindata.org/emissions-by-sector#energy-electricity-heat-and-transport-73-2
Affinché la mobilità possa dirsi sostenibile, è necessario adottare una visione ampia e inclusiva. Sostenibile non significa solo ridurre le emissioni, ma garantire un sistema di trasporti che sia accessibile, durevole nel tempo e attento ai diversi poli d’interesse: ambientale, sociale ed economico.
|
|
Sostenibilità Ambientale |
Sostenibilità Sociale |
Sostenibilità Economica |
|
Aereo |
2.4% delle emissioni globali di CO₂ Forzante radiativo effettivo: 3.5–5% Inquinamento acustico localizzato ma intenso Basso consumo risorsa suolo |
Altissimo livello di sicurezza Connessione tra popoli, culture e territori Accesso diseguale (costi, posizione aeroporti) Ruolo chiave in emergenze e aiuti umanitari |
Settore globale: milioni di impieghi diretti e indiretti Strategico per turismo, business e merci Alti costi di innovazione |
|
Auto |
15–20% delle emissioni globali (incluso traffico e produzione) Rumore diffuso, costante e urbano Alto impatto da infrastrutture e frammentazione ambientale Altissimo consumo della risorsa suolo |
Alta mortalità stradale (5–7 morti per miliardo di pkm) Libertà individuale ma esclusione sociale (disabili, chi non guida) Esposizione elevata a incidenti e inquinamento per residenti urbani |
Industria trainante a livello mondiale Costi sociali elevati (incidenti, sanità, traffico) Tendenza verso mobilità condivisa o elettrica |
|
Treno |
Impatto variabile in base al mix energetico nazionale Emissioni quasi nulle dove l’elettricità è rinnovabile Rumore contenuto e concentrato Consumo significativo della risorsa suolo |
Molto sicuro (0.2–0.5 morti per miliardo di pkm) Accessibilità elevata in contesti urbani/metropolitani Inclusivo se ben progettato (stazioni, intermodalità, barriere architettoniche) |
Elevati costi iniziali di infrastruttura Bassi costi marginali di trasporto per passeggero Economia di scala forte su linee dense |
Una mobilità che esclude le persone con disabilità, che penalizza chi vive lontano dai centri urbani o che si traduce in costi proibitivi per la maggior parte della popolazione - magari sotto forma di tasse disincentivanti - è tutto fuorché sostenibile. Cristallizzare l’immobilità come ideale ecologico, riservando la possibilità di spostarsi solo a chi può permetterselo, significa rinunciare al principio stesso di equità. La vera sfida consiste nello sviluppare un modello di mobilità che unisca responsabilità ambientale e giustizia sociale, evitando scorciatoie moralistiche e affrontando la complessità sistemica con lucidità e trasparenza.
Rimettere al centro i dati e il contesto non significa ignorare le sfide ambientali del settore aereo. Come per ogni modalità di trasporto, anche l’aviazione deve affrontare un percorso di innovazione: l’introduzione di carburanti sostenibili, l’ottimizzazione delle rotte, il miglioramento dell’efficienza energetica degli aeromobili e lo sviluppo di tecnologie ibride o elettriche per tratte brevi sono segnali concreti di una direzione possibile.
Aerei
- L’efficienza per litro di carburante per passeggero-chilometro (pkm) è migliorata di circa 1–2% all’anno negli ultimi decenni.
- Secondo IATA, gli aerei moderni consumano oggi il 70-80% in meno di carburante per pkm rispetto agli anni Sessanta del Novecento.
- Tuttavia, i guadagni di efficienza stanno rallentando perché si sono già raggiunti molti traguardi tecnologici (motori più leggeri, materiali compositi, ali ottimizzate).
- Le emissioni non dipendono solo dalla CO₂: il forzante radiativo in quota (NOx, vapore acqueo, scie di condensazione) rimane un fattore significativo.
Auto
- Le auto moderne (soprattutto in Europa e Asia) sono molto più efficienti di 20-30 anni fa, grazie a miglioramenti nei motori a combustione interna, veicoli ibridi/elettrici e ottimizzazione dell’aerodinamica e riduzione del peso.
- L’introduzione di normative ambientali (Euro 6, 7...) ha spinto fortemente l’industria verso consumi più bassi.
- In media, un’auto a benzina del 2020 consuma il 20-30% in meno di un modello del 2000 a parità di prestazioni.
- Le auto elettriche sono più efficienti, ma il loro impatto ambientale dipende dalla fonte dell’elettricità.
Treno elettrico
- È il mezzo più efficiente in assoluto: nel 2020 consuma in media 0.2 MJ/pkm, contro 0.45 MJ/pkm nel 1990 (-55%). Il miglioramento è dovuto alla diffusione dell’elettrificazione ferroviaria, la frenata rigenerativa, motori a induzione, aerodinamica migliorata, gestione intelligente della trazione e treni più leggeri.
- I benefici ambientali variano a seconda del mix energetico nazionale.
Allo stesso tempo, politiche pubbliche efficaci dovrebbero incentivare la complementarità tra mezzi – come l’intermodalità treno-aereo – senza ricorrere a misure punitive che rischiano di colpire solo chi ha meno alternative. Una visione lungimirante consente di superare l’ossessione per capri espiatori simbolici e di concentrare l’attenzione su strategie strutturali e inclusive, capaci di ridurre le emissioni senza compromettere mobilità, accessibilità e giustizia sociale. Non si tratta di "vergogna" o "innocenza", ma di coerenza, responsabilità e intelligenza collettiva.
Fonti
- Chester, Mikhail, and Arpad Horvath. 2009. Environmental Assessment of Passenger Transportation Should Include Infrastructure and Supply Chains. Environmental Research Letters 4 (2): 024008. https://doi.org/10.1088/1748-9326/4/2/024008.
- ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. n.d. Le emissioni gassose. https://www.enac.gov.it/ambiente/le-emissioni-gassose-2.
- European Environment Agency (EEA). 2020–2021. Transport and Environment Reports. Copenhagen: EEA. https://www.eea.europa.eu/themes/transport.
- ICCT – International Council on Clean Transportation. 2021. Real-World Usage of Electric Vehicles in Europe. https://theicct.org/publication/real-world-usage-of-electric-vehicles-in-europe/.
- ICAO – International Civil Aviation Organization. 2019. Environmental Report 2019: Aviation and Environment. Montréal: ICAO. https://www.icao.int/environmental-protection/pages/env2019.aspx.
- IEA – International Energy Agency. 2021. World Energy Outlook 2021. Paris: IEA. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021.
- Our World in Data. 2022. Emissions by Sector. Oxford Martin School, University of Oxford. https://ourworldindata.org/emissions-by-sector.
- Our World in Data. 2022. Energy Intensity of Passenger Transport. Oxford Martin School, University of Oxford. https://ourworldindata.org/grapher/energy-intensity-of-passenger-transport.
- Öko-Institut. 2020. CO₂-Bilanzen im Verkehr: Infrastruktur berücksichtigen. Berlin: Öko-Institut. https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/CO2-Bilanzen-im-Verkehr.pdf.
- Smil, Vaclav. 2021. I numeri non mentono: Brevi storie per capire il mondo. Torino: Einaudi. (Titolo originale: Numbers Don’t Lie: 71 Things You Need to Know About the World, 2020).
- Transport & Environment. 2020. How Clean Are Electric Cars? Brussels: T&E. https://www.transportenvironment.org/discover/how-clean-are-electric-cars/.
- UIC & IEA – Union Internationale des Chemins de fer and International Energy Agency. 2014. Railway Handbook 2014: Energy Consumption and CO₂ Emissions. Paris: IEA. https://uic.org/IMG/pdf/iea-uic_railway_handbook_2014.pdf.
- van Essen, Huib, Maartje Schroten, Mart Bolech, and Borys Sutter. 2019. Handbook on the External Costs of Transport. CE Delft for the European Commission. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9784b4f3-8448-11e9-9f05-01aa75ed71a1.
Tutte le stime sulle emissioni per mezzo di trasporto (g CO₂/pkm o MJ/pkm) fanno riferimento a medie europee, tenendo conto di tassi di occupazione realistici.
Il forzante radiativo è una misura dell’alterazione dell’equilibrio energetico del sistema climatico terrestre, espressa in watt per metro quadrato (W/m²). L’aviazione, oltre alla CO₂, emette altri agenti climatici come NOₓ, vapore acqueo e scie di condensazione, che amplificano il riscaldamento globale. Secondo le più recenti valutazioni (es. IPCC, Lee et al. 2021), il contributo complessivo dell’aviazione al riscaldamento globale, considerando il forzante radiativo, è stimato attorno al 3.5-5%.
Maggiori dettagli sulle alterazioni degli ecosistemi e le interazioni antropiche:
https://rhpositive.net/index.php/articoli/33-le-alterazioni-dell-ecosistema
Roland Hochstrasser, geografo
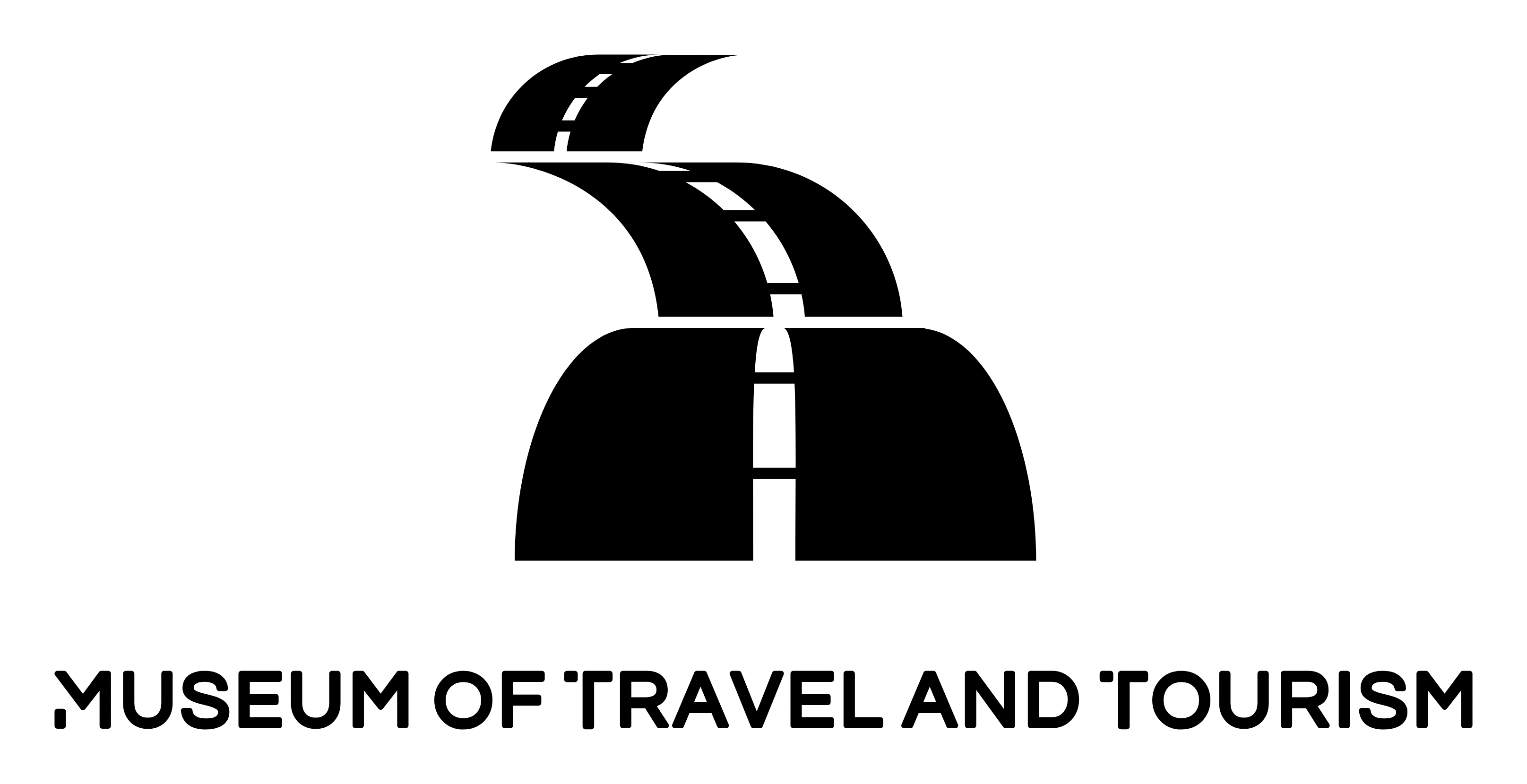
 Italiano
Italiano  Français
Français  Deutsch
Deutsch  English
English 